 La “Rivista Italiana di Letteratura Dialettale” è un periodico trimestrale fondato e diretto da Salvatore Di Marco, pubblicato a Palermo dalla Fondazione Ignazio Buttitta con il contributo della Regione Sicilia, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Nel n. 3, anno II, dicembre 2007, nuova serie, nelle pagine dedicate ai “Saggi” si possono leggere un testo di Fernando Grignola “La lezione di Buttitta: un popolo diventa servo quando gli rubano la lingua”, che chiude così: «Ma oramai la realtà è quella che è, ed il dialetto sarà fatalmente sempre più abbandonato sotto l’incalzare multietnico (reputato per vari aspetti un arricchimento) della società ticinese [Grignola è ticinese]. Basta osservare la molteplice provenienza delle naturalizzazioni acquisite negli ultimi decenni per rendersene conto. Per tornare all’inglese, io stesso, del resto, sto scrivendo queste righe sullo schermo che sottintende dominanti Windows, Microsoft, Word e Layout estranei alla mia anima, ma estremamente veloci e funzionali in aiuto della creatività. Ciò non mi impedisce, pensando al dialettale impoverimento linguistico imposto dai business mondiali ai nostri inconsapevoli e orfani nipoti, di essere molto triste per loro. E per i gioielli che hanno perso per sempre.»
La “Rivista Italiana di Letteratura Dialettale” è un periodico trimestrale fondato e diretto da Salvatore Di Marco, pubblicato a Palermo dalla Fondazione Ignazio Buttitta con il contributo della Regione Sicilia, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Nel n. 3, anno II, dicembre 2007, nuova serie, nelle pagine dedicate ai “Saggi” si possono leggere un testo di Fernando Grignola “La lezione di Buttitta: un popolo diventa servo quando gli rubano la lingua”, che chiude così: «Ma oramai la realtà è quella che è, ed il dialetto sarà fatalmente sempre più abbandonato sotto l’incalzare multietnico (reputato per vari aspetti un arricchimento) della società ticinese [Grignola è ticinese]. Basta osservare la molteplice provenienza delle naturalizzazioni acquisite negli ultimi decenni per rendersene conto. Per tornare all’inglese, io stesso, del resto, sto scrivendo queste righe sullo schermo che sottintende dominanti Windows, Microsoft, Word e Layout estranei alla mia anima, ma estremamente veloci e funzionali in aiuto della creatività. Ciò non mi impedisce, pensando al dialettale impoverimento linguistico imposto dai business mondiali ai nostri inconsapevoli e orfani nipoti, di essere molto triste per loro. E per i gioielli che hanno perso per sempre.»Sempre nella stessa sezione “Bèrghem de sass” di Liana De Luca, da cui traggo questa chiamata di corresponsabilità: «Causa determinante dell’appiattimento linguistico, non solo a sfavore dei dialetti, ma a impoverimento della lingua italiana, è da imputare alla televisione… Il mass-media ha però svolto la funzione di diffondere l’italiano, sia pure in forme rudimentali e spesso gergali, e di facilitare i rapporti fra le varie regioni». Chiude la sezione “Amore e fiele nel canzoniere di Assunta Finiguerra” di Marco I. de Santis, in cui, attraverso molte citazioni si rileva «come, nelle pieghe di una straordinaria ricchezza metaforica, la lirica di Assunta Finiguerra sia verbo fatto carne, poesia concreta, nutrita di cose, piante e animali, impastata di sangue, lacrime e fiele, per gridare in eterno a tutti una ribellione contro la vita e la società, che invece di donare luce e ambrosia ai suoi figli, gli han solo dato buio e cicuta.»
“Studi Regionali” presenta un articolo di Carmine Chiodo, “Il dialetto del Tirreno cosentino: Il lessico dei pescatori”, ed un testo di Gabriele Ghiandoni, “Tre poeti «unius libri»”. In “Crestomazia Dialettale” poesie di numerosi autori tra cui lo stesso Salvatore Di Marco e, senza togliere nulla agli altri, cito anche le due poesie in lingua friulana di Novella Cantarutti.
In profili critici, un saggio di Maria Nivea Zagarella, “Originalità e modernità di un intellettuale siciliano del Quattrocento”, di cui l’incipit: «Nel processo di evoluzione del teatro cristiano, che dai drammi liturgici latini dell’alto medioevo, attraverso le laudi drammatiche umbre del Duecento, porta all’affermarsi nel secolo XV del dramma sacro, “La Ressurressioni” del siracusano Marco De Grandi, redatta in siciliano letterario e parlato, strutturalmente e contenutisticamente si colloca fra vecchio e nuovo». Segue un articolo di Marco Scalabrino, “Aldo Grienti e la nuova poesia siciliana”.
Per “Letture”, Sergio Spadaro ci presenta “Le «soledades» del calabro Panetta”: «Anche la Calabria meridionale jonica dà voce letteraria e vernacolare con Alfredo Panetta, attraverso la silloge di liriche “Petri ’i limiti” (“Pietre di confine”, Moretti e Vitali, Bergamo 2005), alle sue più radicate solitudini esistenziali e sociali. Quelle di Panetta non sono infatti “soledades” soltanto personali, ma riescono a esprimere la storica condizione di arretratezza e di abbandono della sua gente, la sua emarginazione persino nel contesto delle altre regioni italiane del Sud». Gabrio Vitali, con l’articolo “Le narrazioni poetiche di Lino Angiuli”, ci ricorda che «La poesia di Angiuli “trasforma il lettore in interprete di una drammatizzazione sonora e visiva, dove le figurazioni si trasformano in figure e dove ogni movimento diventa metafora di un sentimento”. Così Raffaele Crovi nella prefazione di “Catechismo”, una delle raccolte precedenti di questo sapiente poeta pugliese, ironico e ricco di pietas. La lettura dei versi di un “Un giorno l’altro” fa sentire ancora pertinenti quelle considerazioni, ma fa anche pensare ad un’avvenuta maturazione del dettato poetico dove figure. movimenti e sentimenti si allacciano nella tramatura di una prosodia che diventa racconto.»
Chiude “Letture” l’articolo di Marco I. de Santis, “Pë ttèëchë (Per te), l’amore secondo Domenico Amato” che presenta la quinta silloge di poesie del poeta, uscita nelle edizioni La Vallisa di Bari (2007).
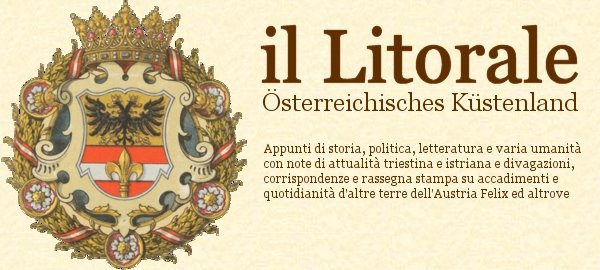
Nessun commento:
Posta un commento